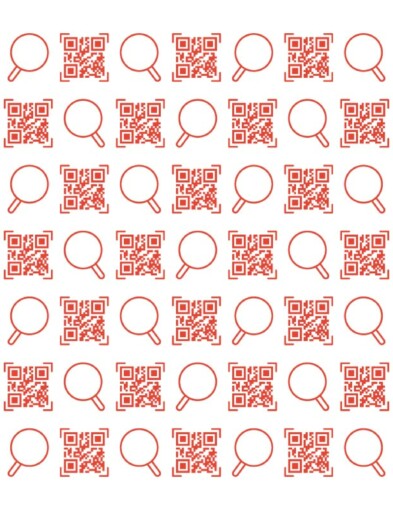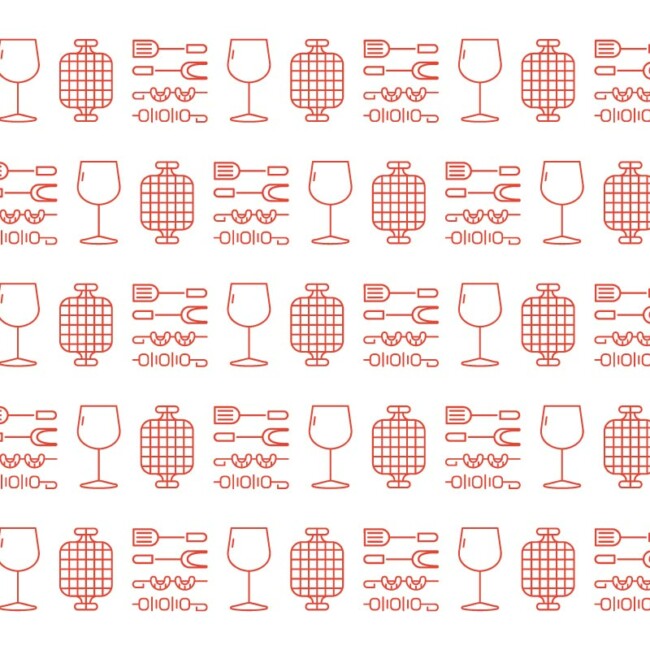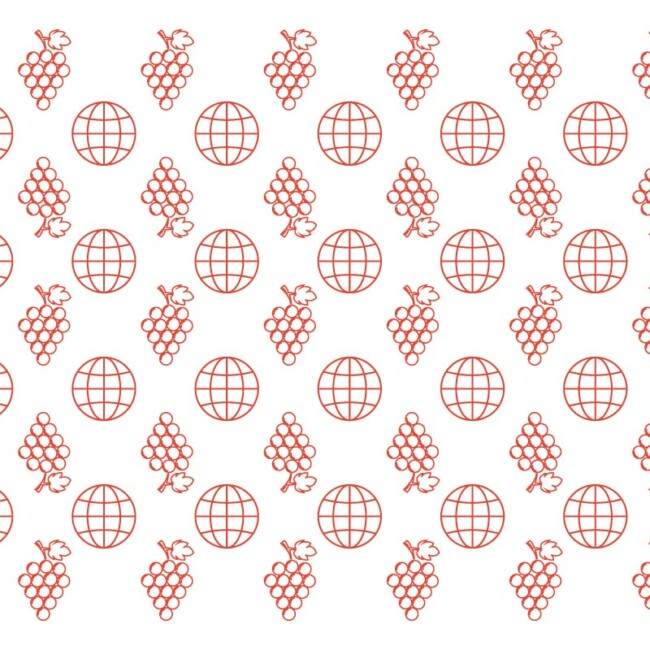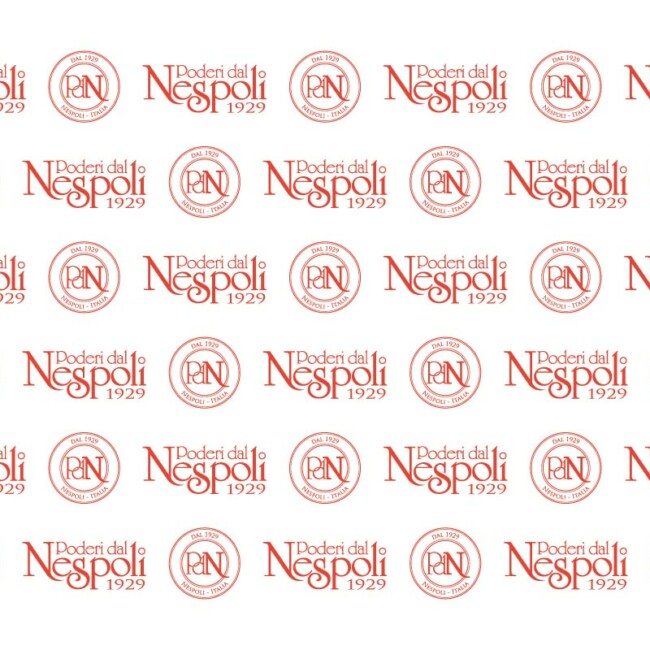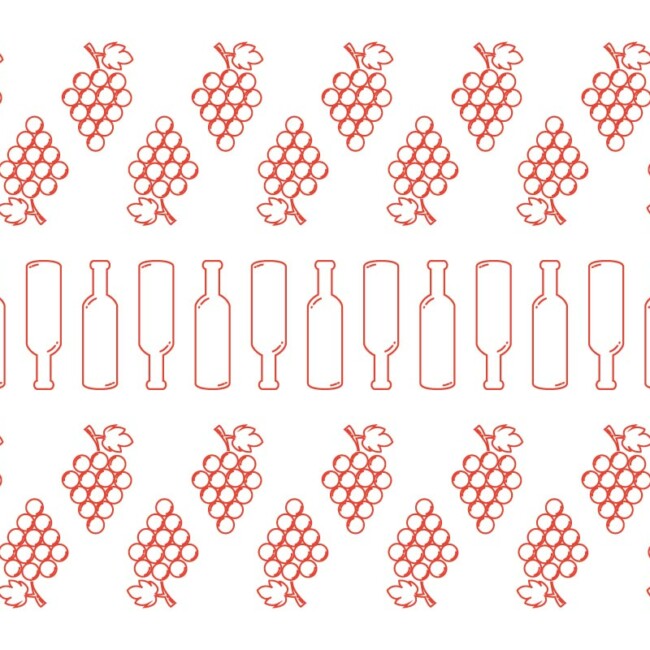1. La doppia etichetta: frontale e retro etichetta
Le bottiglie di vino presentano generalmente due etichette: l’etichetta frontale, quella più visibile, è pensata per caratterizzare il brand attraverso un design attraente per il consumatori, e contiene di solito informazioni minime quali il marchio, il nome del vino, la denominazione e a volte l’annata.
La retro etichetta fornisce tutte le informazioni di legge e i dettagli quali nome e denominazione corretta, annata (ad esclusione dei vini no vintage), Paese di produzione, codice identificativo del produttore e imbottigliatore, allergeni.
Ogni produttore decide quante e quali informazioni inserire, purché rispetti gli obblighi normativi previsti dalla legge italiana ed europea.
In alcuni casi il produttore decide di utilizzare solo un’etichetta, che in questo caso conterrà tutte le informazioni necessarie.
2. Il nome del vino
Il nome del vino può essere un nome di fantasia scelto dal produttore (ad esempio “Prugneto”), o può coincidere con il vitigno (ad esempio “Montepulciano d’Abruzzo”) o la denominazione di origine (ad esempio “Barolo DOCG”)
Nel caso di un nome di fantasia, l’etichetta riporterà comunque la denominazione e/o il vitigno da cui è prodotto, in modo da fornire al consumatore tutte le indicazioni necessarie.
3. Il vitigno o i vitigni
Il vitigno è la varietà di uva da cui è prodotto il vino. In Italia, se ne contano oltre 500 registrati, rendendo il panorama vitivinicolo uno dei più ricchi e complessi al mondo.
Quando un’etichetta riporta il nome del vitigno, questo indica che almeno l’85% delle uve utilizzate proviene da quella varietà, secondo le normative.
Nel caso di vini da uvaggi (blend), l’etichetta può indicare i vitigni principali o riportare solo la denominazione.
4. La denominazione di origine
La denominazione costituisce una delle informazioni più importanti: in Italia, le denominazioni certificano l’origine geografica del vino e ne regolamentano i metodi di produzione.
La classificazione vini prevista dalla Comunità Europea suddivide i vini prodotti negli stati membri in due categorie fondamentali:
• i vini non necessariamente riconducibili a vitigni o zone di origine ben definite, che non sono vincolati da specifiche regolamentazioni di produzione;
• i vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), che mantengono una stretta correlazione con il territorio di origine e sono soggetti ad una vinificazione regolamentata da disciplinare di produzione. L’Italia ha introdotto alcune varianti rispetto alle indicazioni Europee, tra cui l’indicazione IGT anziché IGP e l’utilizzo della classificazione DOC e DOCG invece di DOP.
• DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita
È il massimo riconoscimento per un vino italiano. Indica che il vino è stato prodotto seguendo regole molto restrittive, in una zona specifica, con controlli di qualità aggiuntivi, anche attraverso degustazioni ufficiali.
I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita sono caratterizzati da uno speciale contrassegno, una fascetta stampata e fornita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) al produttore per ciascun lotto di produzione, che ne certifica l’autenticità e rappresenta un sistema anti contraffazione per consentire la tracciabilità dei vini.
Sulla fascetta delle DOCG si trovano sempre 6 elementi: il logo dello Stato, avvolta dalla dicitura “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, la sigla D.O.C.G., un codice progressivo di identificazione, la serie alfanumerica del contrassegno, il volume nominale del prodotto espresso in litri, il codice di identificazione e il volume in formato di codice a barre, eventuale nome del Consorzio a cui la denominazione fa riferimento.
Nel 2025 si contano 78 denominazioni DOCG in Italia.
Esempi di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita: Barolo DOCG, Alta Langa DOCG, Romagna DOCG Albana.
• DOC – Denominazione di Origine Controllata
Un gradino sotto la DOCG, ma comunque sinonimo di qualità. I disciplinari di produzione delle DOC regolano i vitigni ammessi, le zone di produzione e altri aspetti tecnici.
Anche alcune D.O.C. prevedono il contrassegno di Stato, contenente informazioni utili e con la stessa funzione della fascetta delle D.O.C.G.
Nel 2025 sono presenti 341 vini a denominazione DOC in Italia.
Esempi di vini a Denominazione di Origine Controllata: Montepulciano d’Abruzzo DOC, Prosecco DOC, Sicilia DOC, Etna DOC.
• IGT – Indicazione Geografica Tipica
Classificazione più flessibile rispetto a DOC e DOCG, i suoi requisiti base si applicano ai vini che vengono prodotti nella rispettiva indicazione geografica, cioè almeno l’85% delle uve da cui sono prodotti provengono da tale zona geografica, spesso riferendosi ad aree estese come una regione o una provincia. La IGT è spesso usata per vini moderni o internazionali. In questo caso non è presente alcun contrassegno di Stato.
Nel 2025 in Italia esistono 118 denominazioni IGT.
Esempi: Puglia IGT, Terre Siciliane IGT, Rubicone IGT, Trevenezie IGT.
• Vino (ex “Vino da Tavola”)
In questa classificazione sono compresi vini che non hanno riferimento all’indicazione geografica e possono essere prodotti con uve provenienti da diverse zone o Stati Membri. Possono riportare in etichetta l’annata e/o il riferimento al/ai vitigni utilizzati (questa indicazione è limitata solo per alcune varietà tra cui Cabernet, Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Syrah). Sono soggetti a minori limitazioni in quanto non rientrano in stringenti disciplinari di produzione.
5. L’annata
Per i vini a Denominazione di Origine e IGT, quando previsto dal disciplinare di produzione, è obbligatorio riportare in etichetta l’annata, dato che indica che almeno l’85% delle uve utilizzate è stato raccolto in quell’anno.
Non è obbligatorio, ma facoltativo, riportare l’annata sui vini varietali, indicando anche in questo caso che almeno l’85% delle uve con cui è prodotto il vino è stato vendemmiato nella stessa annata. Sui vini generici invece non si possono riportare in etichetta le annate.
L’informazione dell’annata di raccolta è importante proprio perché ogni vendemmia è influenzata da fattori pedo-climatici che possono determinare il profilo del vino.
6. Il produttore o imbottigliatore
L’etichetta del vino deve riportare il nome o ragione sociale, il comune e lo Stato membro della sede dell’imbottigliatore. Se l’imbottigliamento è conto terzi, si usa la formulazione “imbottigliato da… per conto di…”, con relativi indirizzi. L’imbottigliatore effettivo può essere indicato in codice ICQRF (codice identificativo rilasciato dall’Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi), purché compaia in chiaro un soggetto del circuito commerciale con la specifica di comune e Stato.
7. Gradazione alcolica
Espressa in percentuale di volume (% vol), la gradazione indica la quantità di alcol contenuto nel vino. La gradazione può fornire un’idea della struttura e della forza del vino.
8. Volume della bottiglia
L’etichetta di una bottiglia di vino deve inoltre riportare il volume netto del vino contenuto, espresso in litri, centilitri o millilitri.
9. Lotto
Codice alfanumerico definito dall’imbottigliatore, che identifica un insieme di bottiglie confezionate all’interno della stessa produzione, in un ristretto lasso temporale e in condizioni identiche. È lo strumento di rintracciabilità del prodotto in caso di controlli qualitativi.
Deve essere ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, non obbligatoriamente inserito in etichetta.
10. Allergeni
Dal 2005 è obbligatorio riportare la presenza di allergeni, primo fra tutti: “Contiene solfiti”, da scrivere nella lingua di produzione e di destinazione del mercato in cui il vino sarà venduto.
I solfiti sono conservanti naturali o aggiunti per preservare il vino dall’ossidazione. Sono generalmente innocui, ma devono essere segnalati per legge.
11. Etichettatura ambientale
Entrata in vigore dal 1 gennaio 2023, è d’obbligo riportare in etichetta le modalità di riciclo del packaging (normativa Italiana, non obbligatoria per l’estero), l’elenco degli ingredienti e i dati nutrizionali come previsto dalla normativa Europea. Visto lo spazio limitato, generalmente queste informazioni sono raggiungibili attraverso un QR code presente in etichetta.
In conclusione, l’etichetta rappresentala carta d’identità del vino, un passaporto del gusto, una guida per orientarsi tra le mille sfumature della nostra tradizione vitivinicola.
Saperla leggere non è solo utile, ma può trasformare il tuo approccio al vino, rendendolo più consapevole, curioso e personale.
La prossima volta che avrai in mano una bottiglia, prova a leggerla con occhi nuovi: ogni parola, ogni sigla, ogni numero racconta una storia. La storia di quel vino… e forse anche un po’ la tua.






 Torna indietro
Torna indietro







 Torna indietro
Torna indietro